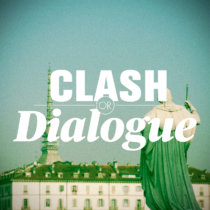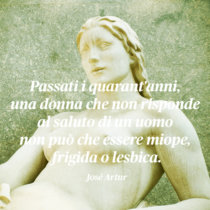Il viaggio sostiene Franco La Cecla è una grande forma di metempsicosi, un processo che attraverso l’esposizione ad una condizione di “fuori luogo” e ad un sentimento di indeterminatezza costante, permette di passare ad “altro” da sé. Questo mutamento si articola secondo Eric J. Leed in tre fasi: partenza, transito, arrivo, ognuna delle quali comporta delle alterazioni del tutto peculiari nell’identità dei viaggiatori. Le motivazioni che spingono al viaggio possono essere di varia natura, ma la distinzione principale che possiamo operare è tra viaggio come necessità o come volontà; nonostante ciò si può ritenere che la triade precedente interessi entrambi i casi. La partenza rappresenta sempre il momento in cui si compie il distacco di un membro dal corpo sociale di appartenenza, da tutta la trama di relazioni che lo rendono identificabile. Con questa frattura l’attore sociale diviene un’individualità autonoma, che mantiene legami virtuali col luogo attraverso il seguito di uomini o il complesso di cose che si porta appresso.

Con l’istituzione del corpo viaggiante, l’organismo sociale diviene trasportabile, rendendosi utile per affrontare i pericoli e le incertezze del viaggio o più semplicemente i momenti di solitudine o nostalgia. Questo processo di incorporazione è importante perché delinea i contorni dell’identità e permette, come nel caso delle spedizioni armate, una sua possibile espansione nello spazio (territori) e nel tempo (memoria), che si realizza nel corso del transito o con l’arrivo. Il topos del viaggio eroico, nella sua forma circolare, attribuisce un’importanza del tutto peculiare all’estensione geografica e temporale dell’identità, in quanto fama, nome e reputazione, perché è l’intera società in questo modo ad essere trasformata in “corpo viaggiante”. Si pensi alla figura medievale del cavaliere errante, che considera la mobilità territoriale come un mezzo per ottenere mobilità sociale. Le gesta eroiche rappresentano l’unica possibilità che gli viene offerta da una società rigidamente divisa e gerarchizzata di intraprendere un’ascesa sociale; e per questo motivo sono arditamente ricercate.

Il viaggio determina una mutazione del rapporto col luogo, fungendo da forma di nobilitazione. È utile ricordare che la mobilità sociale è un “premio” per aver sopportato le sofferenze, i patimenti e le riduzioni comportati dall’allontanamento e dal continuo riposizionamento che la condizione errabonda richiede. Attraverso il transito si verificano trasformazioni assai profonde che coinvolgono la mente, il corpo e lo spirito del viaggiatore e che lo qualificano all’interno di una società territorializzata come una persona fuori dal comune, degna di essere ascoltata o di fungere da modello. Il transito è un evento qualitativamente diverso sia dalla partenza che dall’arrivo, perché è un’esperienza di puro movimento, attraverso i confini e nello spazio, che esclude qualsiasi riferimento ai legami col luogo e interessa esclusivamente chi lo compie. Il movimento, in questa fase del viaggio, oltre a determinare alterazioni fisiche, diviene anche mezzo di percezione, di un mondo oggettivato in immagini e di una identità in costruzione.

Esso promuove nel viaggiatore la coscienza della propria natura di spettatore e osservatore di un mondo passante, che in quanto tale si dà solo come successione di vedute più o meno articolate a seconda della velocità dello spostamento. Nello specifico l’osservazione permette di enucleare le caratteristiche persistenti e formali di alcuni oggetti che, estrapolati dai contesti particolari, acquisiscono un’identità e una validità concettuale generale, indipendentemente dagli accidenti delle loro apparenze (Leed Eric J., La Mente del Viaggiatore, pag.93). Il viaggio si configura come un’attività di costante mediazione, confronto e paragone che acquisisce una scientificità nella misura in cui promuove la ricerca di somiglianze, differenze, variazioni e persistenze in contesti alieni gli uni rispetto agli altri. Non a caso, nota Georg Simmel, l’obiettività dell’estraneo nasce proprio dall’esigenza di una riflessione comparativa e dalla capacità di astrazione dei rapporti dai loro termini locali. Per cogliere però le relazioni che interessano i medesimi oggetti in contesti differenti bisogna arrestare il movimento e con esso quello stato di flusso attraverso il quale l’io e il mondo si uniscono e rimescolano l’uno nell’altro.

Si procede in questo modo ad un distanziamento dalla realtà, che torna a risolversi nei suoi elementi separati. L’interruzione del movimento in molti casi può coincidere con l’arrivo, processo lento di una nuova identificazione col luogo, che si realizza in primis con l’attraversamento del confine, sul quale si gioca la possibilità di inclusione-incorporamento o di esclusione dell’estraneo. Posto che il luogo si risolva nei rapporti di identità che lo sostanziano, l’ingresso al suo interno di un’identità aliena determina processi di riflessione che scompaginano l’ordine pre-esistente, che possono in quanto tali essere rifiutati o accolti. Il confine diviene il simbolo non solo della differenza, ma anche quella soglia in cui si gioca il desiderio o il rifiuto della contaminazione, e nel contempo l’identità dello straniero, che viene definita in relazione alle modalità del suo ingresso: violento o pacifico. Se il viaggiatore entra nel luogo nella maniera giusta egli è fonte di potenza, mentre se entra in maniera impropria è un invasore. Il passaggio al nuovo luogo può avvenire per mezzo di una battaglia o tramite un’incorporazione di natura sessuale o rituale. Esiste anche la possibilità che allo straniero venga negata l’ospitalità; egli diviene in questo caso figura marginale, da temere più che da ammirare, il cui andare è simile al vagare. E del viaggio rimane solo il carattere liminale, il porsi tra ordini istituiti, luoghi, comunità, legami (Fiorani Eleonora, La Nuova Condizione di Vita, pag.62), il vivere della loro assenza.

La frontiera diviene così il nuovo spazio da abitare, conquistare, pensare, condividere nella comunione dell’esclusione, articolando e costruendo nuove pratiche comunicative e identitarie, anche se instabili. Il viaggio volontario non è la forma caratteristica della stragrande maggioranza dei viaggi umani, compiuti da: nomadi, esuli, profughi, prigionieri, schiavi, fuggiaschi e contrassegnati da partenze forzate che nella maggior parte dei casi non contemplano ritorno. In questo caso ad essere vivi sono il sentimento di non appartenenza assoluta, la sensazione di non esserci, piuttosto che la spinta verso l’affermazione dell’identità. Nello specifico l’estraniazione e l’emarginazione che contraddistinguono la figura del migrante oggi non sono propri del viaggio e non generano la figura del viaggiatore. Egli è piuttosto il più delle volte l’escluso, il confinato, non è l’Ulisse vagabondo della mitologia, di cui sono state narrate le gesta eroiche, ma il nulla, il non essere, ai bordi di ogni società e su cui grava il peso dell’inciviltà. È colui che nell’era della globalizzazione, in cui la geografia diviene democratica solo per pochi, viene fermato alle frontiere o che sosta per giorni negli aeroporti in attesa di un visto d’ingresso, colui che abita le zone interstiziali dello spazio urbano, dove prendono corpo pratiche creole e si verificano nuove interferenze tra culture.

Confini e frontiere nella moderna società di viaggiatori si moltiplicano, mutando di statuto e di significato. I confini non sono più fonte di potenza e differenza, ma si riducono a barriere che permettono o negano l’accesso. Nella modernità liquida, nella mobilità permanente degli uomini e delle cose, l’accesso sostituisce le pratiche dell’ingresso, risolvendo il luogo in un locale, assegnandovi altri valori e sensi. Si parla di spazi piuttosto che di luoghi, ritagli di territorio da difendere per rimarcare delle identità assenti, o che necessitano di essere temporaneamente ricostruite. È così che nell’era del consumo e del post-turismo, dove pochi possono permettersi il lusso di glissare la geografia saltellando tra un nodo e l’altro di una rete che connette nonluoghi, il viaggio perde la sua dimensione eroica, non configurandosi più come un modo per scegliere l’immortalità, iscrivendosi nello spazio della terra e nel tempo della memoria, ma trasformandosi in un momento di evasione e di intrattenimento, che riduce il pensiero della differenza alla stregua della ricerca di sempre nuove e diverse esperienze.
Saggio tratto da Extended Mind. Viaggio, comunicazione, moda, città, a cura di Carlotta Petracci, anno 2006.