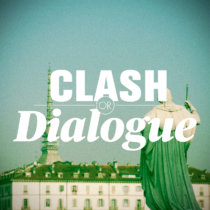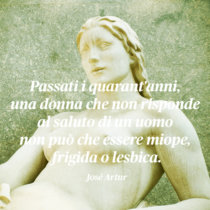Nel 1939 Aime Césare, col suo Cahier d’un retour au pays natal, conia il termine negritudine, con il quale identifica una condizione abitativa complessa e ibrida che legge nel paese natale ritrovato il luogo delle origini e dell’evasione dal presente, ponendo le basi per l’avvio delle critiche postcoloniali che, a partire dagli Anni Cinquanta, mettono in relazione sapere antropologico e colonialismo, quest’ultimo nella forma delle ideologie europee di dominio e potere sull’alterità umana e naturale. Cosicché lo squilibrio generatosi a causa del parlato di una sola soggettività entra in crisi di fronte alle nuove rivendicazioni indipendentiste delle popolazioni subalterne – asiatici, africani, arabi, isolani del Pacifico, indigeni americani – che, accomunati da esperienze di perdita e sottomissione più o meno violente, determinate dall’egemonia politico-culturale occidentale, palesano esigenze di apertura verso nuove forme del discorso interculturale. Forte entro questo contesto critico è la voce della diaspora africana che puntando l’attenzione sull’esperienza dello schiavismo rilegge la storia ufficiale da una posizione insieme marginale e mobile, che nella nave negriera, intesa come “sistema vivo micropolitico e microculturale in movimento” (Gilroy Paul, in Canevacci Massimo, Sincretismi, pag.83), ritrova il suo cronotopo di riferimento.

Uno spazio-tempo in cui si danno anticipazioni di una nuova modernità, sempre più transnazionale e transculturale. Il giudizio sull’Occidente moderno, composito quanto ondivago, per via della molteplicità delle soggettività coinvolte, si fa più perentorio e potente nel momento in cui viene tradotto nella forma dell’Orietalismo di Edward Said. In questo saggio a essere indagata è la modalità attraverso cui l’Occidente europeo ha creato l’opposizione Noi-Loro e ricondotto l’alterità entro un sistema unico. Il concetto di Orientalismo perciò non va letto nei termini di semplice anti-imperialismo, ma come sintomo di incertezze generate dalla nuova situazione mondiale, entro la quale – pur esistendo diversi livelli del discorso su sapere e potere, che prendono in considerazione anche le voci negate – non si produce una sua reale destrutturazione in termini macroscopici. Nonostante la prospettiva di Edward Said sia essa stessa dicotomica, a questo autore va il merito di avere screditato una grande varietà di stereotipi “orientalisti”, come: l’eterno e immutabile Oriente; l’insaziabilità sessuale dell’arabo; la qualità femminea dell’esotico; i mercati brulicanti; il dispotismo corrotto; la religiosità mistica, problematizzando lo sguardo occidentale, la sua autorità e tensione universalizzante di ascendenza liberale. Cosa che rende ancora più profonda e dolorosa la ferita che si è aperta nel “Noi”, in merito al rapporto tra rappresentazione e autorappresentazione, rivisto alla luce dell’importanza acquisita dalla dimensione intersoggettiva, nell’antropologia interpretativa geertziana e postgeertziana.

La questione teorica chiave posta da Orientalism riguarda lo statuto di tutte le forme di pensiero e rappresentazione, che servono a trattare ciò che è alieno e che sono determinate da “archivi” culturali utili a sistematizzare la differenza entro totalità organiche tenute insieme dalla lingua e dal luogo. Affermazione che motiva non solo la consapevolezza relativa alla contingenza e alla natura finzionale delle definizioni culturali ma anche la presa di coscienza in merito all’analogia tra gli assunti organicisti di una prima modernità (ottocentesca) e i recenti modelli semiotici o simbolici, che concepiscono la cultura come comunicazione. Da cui l’esigenza del superamento del concetto di cultura e della sua sostituzione con una visione – di foucaultiana memoria – di potenti formazioni discorsive che si dispiegano globalmente e strategicamente; insiemi di relazioni per cui le identità, non più date, vengono sempre negoziate, in termini non solo di apparenze ma anche di potere. Non si sta qui parlando di apertura verso un nuovo relativismo, né tantomeno di caos come anarchia, ma piuttosto di una condizione che, nell’interconnessione e nell’appartenenza a più sistemi comunicativi e nella possibilità di attingere a nuovi modelli, legge la declinazione plurale del soggetto, rendendo esternamente e internamente necessarie dialogica e polifonia.

Tale disgiunzione sta rapidamente collassando le scienze sociali, che non più alle prese col nativo e nemmeno con l’altro, si trovano di fronte allo xavante come Divino Tserewahú, persona in carne e ossa che filma e commenta l’invasione della riserva Macuxi da parte dell’esercito brasiliano (Canevacci Massimo, Sincretismi, pagg. 219-220): protestando attraverso la propria voce e la tecnologia, da troppo tempo ormai prerogativa esclusiva del primo mondo. In questo modo i doppiaggi dell’antropologia vengono meno e il fieldwork viene condiviso; l’oralità è preservata pur nella sua testualizzazione, che la rende disponibile al viaggio e al trasferimento. Siamo oltre alle tecniche dell’etnografia surrealista e al senso di smarrimento del funzionalismo lévi-straussiano; lo spazio globale con le sue tecnologie permette una reale dialogica e polifonia, che pur non intaccando la persistenza delle culture del collezionare, nelle forme dei musei e del turismo, le pone sotto assedio svelandone artificialità costitutiva, fragilità di fronte alla pluralità dell’esperienza metropolitana (ossia in relazione all’habitus di smistare significati, codici e visioni utilizzando più tecnologie) e volontà di potenza, soprattutto in relazione alle seduzioni del consumo.

La cultura del consumo infatti ci pone di fronte a nuovi e vecchi archivi culturali, che fungono da riserve di senso effimero a chiunque si ponga in una prospettiva dislocata e disconnessa dalle proprie matrici culturali etno-territoriali o stato-nazionali e voglia performare autonomamente la propria ricerca etnografica. Entro questa prospettiva troviamo le nuove identità-diasporiche, per le quali la perdita, non più fonte di sofferenza, è speranza e desiderio di alterazione, e l’attraversamento di differenti contesti stranieri, non più fautore di sentimenti di sottrazione, è modus operandi che, al di là di nostalgia e assimilazione, promuove sfide e irregolarità tanto al monocentrismo degli stati quanto al policentrismo del potere economico. La dimensione diasporica attuale, liberandosi anche dalla sua concezione tradizionale, si apre allo sperimentalismo e alle sue regole, che consentono la convivenza di autoaffermazione e irriverenza nei confronti di concetti statici e terze vie attraverso i sincretismi e le provocazioni degli ossimori, come il changing same (Gilroy Paul, Black Atlantic). Il medesimo che cambia così come l’ha definito Paul Gilroy in Black Atlantic è il processo di estraniazione che dimostra la condizione diasporica interna alle diaspore stesse che disgregano la visione della Storia ufficiale non solo in qualità di corpus coeso, ma anche attraverso soggettività specifiche.

Come sistemi di flussi in movimento mettono in crisi ogni pretesa logocentrica e assegnano alla moltiplicazione egoica (da intendersi come trasformazione dell’io in ii. Da cui “io” non più come cardine né principio d’ordine, visto che ciascuna individualità interna mantiene una propria autonomia, che la porta a interfacciarsi con altre individualità e pluralità esterne) una valenza creativa che la sottrae alla perentorietà del giudizio di schizofrenia. La moltiplicazione è vista come dislocazione cognitiva e corporea che permette il dialogo tra mappe di soggettività vecchie e nuove, col fine di promuovere una riperimetrazione, per quanto cangiante, delle geopolitiche del desiderio mediante il transito in between tra globale e locale. Questa condizione è testimonianza di una ricerca spasmodica del proprio sé, rintracciabile nella maniera in cui le postculture, assemblando pratiche, estetiche e linguaggi, si inseriscono nel panorama attuale, attraverso l’arte, la musica, la moda, il cinema, il teatro, la danza, dimostrando come la diversità vada pensata come costrutto relazionale e mutante, e come le opposizioni binarie – Qui-Altrove, Centro-Periferia, Noi-Loro – siano inefficaci se lette a partire da una prospettiva errante, che svela l’interferenza tra postcolonialismo e postmoderno.
Saggio tratto da Extended Mind. Viaggio, comunicazione, moda, città, a cura di Carlotta Petracci, anno 2006. Noi, loro, ii. Parte I.