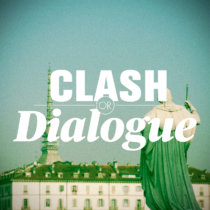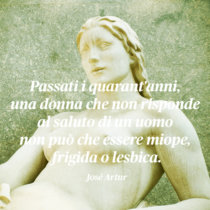La crisi dello stato-nazione, o come osserva Arjun Appadurai il venir meno del trattino che li univa, comporta l’indebolimento della “presunta integrità e unità raggiunte dalla società dello stato-nazione” (Appadurai Arjun, Modernità in Polvere, pag.13), tanto che il vuoto che si apre nel sociale pare venir colmato dalla cultura. La quale, sempre più estesa in significati e difficile da categorizzare, assume un ruolo nuovo che “la pone o la fa apparire oltre il sociale”; o meglio oltre a quello legato all’economia dello stato-nazione, al sistema delle classi, al genere, all’etnicità e al territorio (Eleonora Fiorani, La Nuova Condizione di Vita, pag.185). La sua estensione a cultura del consumo e lo stretto legame intrattenuto con la comunicazione mediatica la rendono inscindibile dalla vita, a tal punto che ogni sua manifestazione può venir commercializzata e acquisire valenza cosmopolita. Il locale, l’etnico, il particolare, si trasformano in significanti viaggianti nel mondo delle reti globali e possono rilocalizzarsi subendo processi di “indigenizzazione”. Questo costante transito di immagini, figure, merci, culture, emozioni, alterità e differenze struttura e smobilita i sogni e i desideri della nuova modernità, anima i suoi molteplici percorsi – turismi, fughe e migrazioni – e promuove le sue mutevoli riscritture.

Il processo di traduzione e trasformazione del moderno non avviene solo all’interno delle nostre società, in cui le minoranze sono state insediate, costruite o vi si sono trasferite, bensì riguarda anche i paesi in cui la modernità prende corpo, siano essi in via di industrializzazione o indigeni, attraverso flussi di immagini, merci, idee, denaro, armi e uomini. I paesi dove viene ripensata a partire da posizioni periferiche che ridisegnano le mappe territoriali delle ex colonie e del Terzo Mondo facendole corrispondere e dialogare con quelle delle comunità etniche e transnazionali che, oggi come ieri, si sono sovrapposte e mescolate a quelle moderne e occidentali. Come nota Eleonora Fiorani: “la riflessione critica sulla modernità è anche un ripensamento della sua immagine e dell’identità che su di essa si è costruita. La storia dell’Europa e dell’Occidente, e quindi anche la sua coscienza, è scritta nella autoreferenzialità: pertanto è una storia monca, depurata della presenza dell’alterità che la costituisce. Si pensa e si ricostruisce nelle emigrazioni che colonizzano altri mondi, ma non nelle migrazioni che le sono altrettanto strutturali” (Fiorani Eleonora, La Nuova Condizione di Vita, pag.187), che ricollegando l’esperienza della colonizzazione e della globalizzazione a quella dell’alterità, della diaspora e della marginalità, ne sottolineano la profonda appartenenza alla cultura moderna e postmoderna, ancora inconsapevole della natura differenziata dei movimenti che la costituiscono.

Il fatto stesso di emigrare implica la decisione di dirigersi verso mondi e realtà di cui si ha una certa conoscenza, e ciò vale sia in rapporto alle grandi ondate migratorie del XIX secolo verso Europa e Nuovo mondo sia in relazione a quelle pendolari che oggi muovono non più solo verso l’Occidente ma in maniera caotica in tutto il mondo globalizzato, portando alle estreme conseguenze i processi di sconfinamento, disintegrazione, ibridazione e mescolanza delle identità e delle culture. La consapevolezza di una storia globale caratterizzata dalla diaspora dei popoli (con le loro diverse lingue, storie e culture) e delle merci genera la percezione di una propria identità culturale come effetto di processi transculturali, che non riguarda più solo le popolazioni periferiche e implica uno spostamento dello sguardo, una ricalibrazione della visione, che delinea un diverso modo di pensare l’attualità e la storia, per trasversalità e dislocamenti. Una storia che deve ancora essere scritta e di cui si cominciano a seguire le tracce nella letteratura, nella musica, nelle identità che arrivano dall’altrove e ci ricordano che le nostre storie e identità vi sono intrecciate. Una storia che ricorda che l’immagine dell’Occidente che la modernità ci ha consegnato ha sin troppo a lungo escluso e dimenticato le voci e i corpi dell’alterità sui quali si è iscritta e ribellata.

Di qui la necessità di un decentramento delle riflessioni critiche sulla modernità e la sua presunta omogeneità, a partire dalle prospettive delineate dagli studi postcoloniali e dai panorami che attualmente fanno transitare e ricostruiscono incessantemente la differenza attraverso l’alterità. Attraverso quell’umanità eccedente e solo apparentemente estranea che dall’interno delle nostre società prefigura la possibilità del “mutevole medesimo”. Non certo senza conflitti. Poiché superare la modernità significa non solo subirla, criticarla e riscriverla dal margine, ma anche e soprattutto avere la possibilità di parteciparla e di farsi partecipare raggiungendo una risonanza ad un tempo locale e globale. In ciò la differenza tra modernità e moderno globale, in cui il binomio migrazione-multimedialità può far dialogare le voci sommerse oltre la frontiera, facendole transitare nello spazio pubblico, modificando la nostra percezione della territorialità, della cultura e della società.

Ritrovare un filo rosso che lega le migrazioni di ieri a quelle di oggi significa smettere di considerare la differenza culturale a partire dalla contrapposizione tra mixofilia e mixofobia, e comprendere che non può essere la paura del disagio sociale a motivare il ritiro entro isole di somiglianza e il disinteresse nei confronti di questa complessa matassa di storie che sono anche le nostre. Nostre non solo nel senso che le abbiamo “prodotte” ma che sono parte integrante della nostra identità: un’identità europea molto più estesa di quanto sino ad ora si sia potuto pensare, che riscopre i suoi volti africani, asiatici, meticci e anche americani, e che torna a guardarsi attraverso una prospettiva mobile, come crogiolo non di territorialità ma di traiettorie. Pensare in questo modo l’identità significa renderla itinerante e costruirla non sopra ma attraverso l’alterità: la contaminazione, lo scambio, il sincretismo e l’invenzione.

Osservando anche come le differenze si modificano e muovono all’interno delle nostre società, in rapporto a quella globale e a quelle locali di provenienza e appartenenza, e come si distinguono da quelle che si sono formate dopo alcune generazioni dall’insediamento delle prime migrazioni. In un’epoca in cui la modernizzazione si è estesa a tutto il globo, la realtà della migrazione ha altre logiche e motivazioni. Il fatto stesso di migrare oggi non è più semplicemente una fuga in vista di un miraggio, ma una necessità, una scelta, a cui si affianca anche il desiderio di ritorno, nell’ottica di contribuire al mutamento della propria terra. Globalizzazione e migrazione determinano la trasformazione di tutti i territori che attraversano e con essi delle identità che, contemporaneamente, mantengono i propri riferimenti, ne aggiungono di nuovi e li raffrontano ponendo in relazione le diverse esperienze della modernità.
Si originano così figure molto più complesse che si mantengono sotto tensione tra una logica identitaria che può condurre al ripiegamento e al settarismo e il desiderio di partecipazione alla vita moderna e globale, da intendersi nel senso di un ritrovamento di riferimenti e appartenenze collettive a partire da esperienze personali, che si iscrivono nello spazio fluido della diaspora, ovvero simultaneamente nelle società di ricezione e in quella di provenienza dove, nella maggior parte dei casi, la globalizzazione ha prodotto le sue gerarchie, esclusioni e ineguaglianze come in passato fecero stati e poteri politici imperiali e coloniali, inventando o esacerbando identità, etnie e nazioni per legittimare la loro supremazia culturale.
Saggio tratto da Extended Mind. Viaggio, comunicazione, moda, città, a cura di Carlotta Petracci, anno 2006.