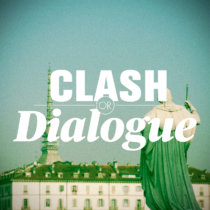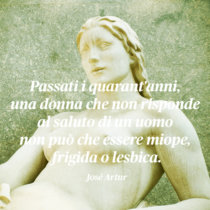Le identità sono immagini che derivano dagli scambi e dai rispecchiamenti tra individualità e alterità. Possono divenire fluide o multiple nella misura in cui si fondano sulla trasformazione delle apparenze sensibili. Questa idea che la realtà sociale derivi dalle apparenze e si trasformi con la loro manipolazione non è affatto nuova; al contrario viene fatta risalire ad un’intuizione di Erving Goffman, che suggerisce la derivazione sociale dell’identità individuale e considera il suo mutamento in relazione all’inserimento presso diversi pubblici o contesti. Questa posizione è stata nota per generazioni di viaggiatori che, col cambiamento di luogo, si sono predisposti a una dialettica di rispecchiamenti costruita sulla base di identificazioni e differenziazioni. La realtà sociale ha origine nella comunicazione, nella manipolazione di simboli e immagini di identità (Leed Eric J., La Mente del Viaggiatore, pag.264). Le posizioni sociali, i ranghi, la classe, il sesso, il gruppo etnico, si costituiscono in relazione alla dialettica tra mobilità e stanzialità.

Il problema però non è stabilire come le identità vengano cambiate per mezzo della mobilità, bensì comprendere come esse vengano limitate e fissate all’interno delle società umane, per far sorgere la struttura sociale. La fissazione dell’identità in immagini è il prodotto del perpetuarsi di rapporti sociali e culturali, che determinano la nascita e il sedimentarsi di comportamenti specifici, che a sua volta istituiscono un potere sociale su cui si può contare. Tutte le società territorializzate, reggendosi su un’infrastruttura di tipi e stereotipi, propongono un concetto di identità fissa, unica e continua, piuttosto che mutevole, molteplice e discontinua. Per questo motivo il viaggio viene considerato un fattore di sovversione di quell’ordine sociale che si è sedimentato e cristallizzato nel tempo, in relazione allo stato sessile e a un pensiero confinato. L’ideale di ordine sociale, proposto per la prima volta da Platone, è caratterizzato dalla corrispondenza tra il modo in cui un individuo è visto da una moltitudine di altri a lui familiari e il modo in cui lui stesso si vede, ossia dall’annullamento di quello scarto tra l’immagine che gli altri hanno di un uomo e quella che lui stesso ha di sé, in cui risiedono le libertà sociali del viaggio.

Quest’ultimo, richiedendo l’adattamento a situazioni fuori dall’ordinario, fa della dissimulazione una questione di sopravvivenza, che può essere fonte di piacere o di sofferenza morale e senso di colpa per il viaggiatore, che raramente riesce ad allontanarsi da un modo di pensare formatosi in relazione alla condizione stanziale. Le dissimulazioni del viaggio sono considerate patologiche dai responsabili del mantenimento della salute e delle virtù sociali. Le identità molteplici, la confusione dei ruoli, le angosce legate allo status, la superficialità, la reputazione di attore e “spirito libero”, con le quali si identifica la figura del viaggiatore o più propriamente dell’estraneo, sono infatti fonte di sospetto e paura per chi si ancora alla “pesantezza” della terra. Allo stesso tempo sono oggetto di ammirazione e desiderio, perché testimoniano la possibilità di un cambiamento che non può avvenire dentro la realtà limitata del confine. Il carattere sovversivo del viaggio motiva la sua organizzazione e istituzionalizzazione all’interno delle società stabili. In particolare, l’istituzionalizzazione di quella realtà impalpabile che è lo status sociale, trova una manifestazione esemplare nel “commercio di prestigio”, attività che interessa ogni società territorializzata.

Il feticismo delle merci, che sono cristallizzazioni di valori sociali, non a caso è rintracciabile tanto alle Isole Trobriand quanto nei mercati capitalistici contemporanei, dove il consumo diventa il segno distintivo dell’identità. Roger Silverstone rifacendosi al pensiero di Jean Baudrillard e Pierre Bourdieu, afferma che “attraverso i nostri oggetti parliamo a noi stessi e fra di noi, dichiarando il nostro status e la nostra distinzione, e delineando in modo attivo e creativo una mappa per la negoziazione della vita quotidiana” (Zanacchi Adriano, Pubblicità: Effetti Collaterali, pag.137). Nella moderna società globale e capitalista viaggio e consumo acquisiscono un’inedita centralità, tanto da divenire esperienze in grado di fondare e determinare la vita di una comunità estesa, che travalica i confini nazionali e poggia su legami effimeri di natura extra-territoriale, contrassegnati da una sensibilità intensa e accelerata. La società di viaggiatori contemporanea come le passate “società itineranti” è formata da segmenti che si scindono in unità più piccole o si fondono in gruppi più ampi, in un processo incessante di aggregazione e disgregazione, che si incanala in aeroporti, strade urbane, stazioni di pullman, aree di sosta, sistemi stradali, templi del consumo ed enclave turistiche.

Queste temporanee riunioni recuperano la ritualità della festa propria dei pellegrinaggi religiosi, con la differenza che alla celebrazione divina sostituiscono quella consumistica. La mancanza di impegno rintracciabile in queste aggregazioni puntuali è una realtà strutturale propria della società dei viaggiatori, che come tutte le “società viaggianti” vive sul disancoramento e sull’estrema fluidità delle identità e dei legami sociali. L’identità infatti viene raggiunta non per mezzo del lavoro o della fatica, ma mediante il consumo, il tempo libero e il commercio di prestigio, ora su scala globale. Così il nostro make up esistenziale è costituito da tutto ciò che consumiamo, ci portiamo appresso o addosso. Siamo “ancor più dei nostri antenati, ciò che mangiamo, beviamo, adoperiamo, guidiamo, indossiamo. Siamo anche il luogo da cui proveniamo, dove ci troviamo, dove siamo diretti” (Leed Eric J., La Mente del Viaggiatore, p.351). Le nostre valigie sono lo specchio di quante immagini di noi vogliamo portarci appresso. Noi sullo sfondo di luoghi familiari e stranieri; noi che torniamo avendo abbandonato o regalato oggetti, che cominciano altri percorsi, intrecciano nuove relazioni affettive e comunicative, ispirano altri sogni e movimenti.
Saggio tratto da Extended Mind. Viaggio, comunicazione, moda, città, a cura di Carlotta Petracci, anno 2006.