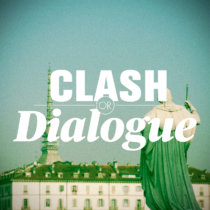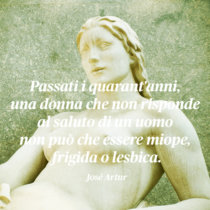La ristrutturazione produttiva avviata dal tardo capitalismo e la convergenza tra economia, cultura, comunicazione e tecnologia determinano non solo l’incremento della complessità dei rapporti planetari tra le varie società: moderne, in via di modernizzazione, misto-moderne o pre-moderne, ma anche la polarizzazione di mondi di vita e lo scardinamento delle appartenenze territoriali e dei meccanismi di riproduzione sociale moderni, tradizionali e locali. Tutto ciò ci pone di fronte alla criticità del problema della differenza culturale, con tutti i risvolti e gli intrecci che essa può schiudere in connessione con storie, processi economici e geopolitici presenti e passati. In merito, tutte le discipline dell’alterità sembrano oggi essere concordi nel ritenere che la differenza culturale non sia più prerogativa di mondi lontani o esotici, ma costituisca una delle principali poste in gioco all’interno delle società più avanzate della “tarda modernità”. Debba cioè essere compresa come parte integrante del lavoro delle società occidentali su se stesse. Non si tratta perciò di valutare semplicemente quei conflitti che scaturiscono ai confini delle nostre e altrui culture, o che potrebbero disegnare le mappe di grandi schieramenti (“choc delle civiltà” di Samuel Huntington) ma di comprendere come la modernità di oggi e di domani accolga, produca e riproduca continuamente le differenze, facendole oggetto d’invenzione.
Se la modernità degli inizi – dei Lumi – ci aveva fatto credere che saremmo stati più moderni quanto più avremmo saputo liquidare i particolarismi culturali e le tradizioni, quella attuale invece non solo riconosce nella ragione uno strumento di dominio etnocentrico, ma recupera il valore di particolarismi e localismi alla luce del mutamento di sguardo che la globalizzazione, con le sue dinamiche di smistamento culturale e scardinamento identitario, richiama. In un mondo densamente informato e connesso come quello attuale sembra non esserci più spazio per comode osservazioni dall’esterno e sterili glorificazioni dell’universalismo occidentale e della sua progressione verso la civiltà. Nonostante ciò, paradossalmente, queste posizioni sembrano essere avvallate proprio dalla globalizzazione stessa e dall’extraterritorialità del suo potere economico. La complessità del presente risiede proprio nelle sue discordanti argomentazioni: da un lato la critica sferrata alla modernità e la speranza della liberazione postmoderna, e dall’altro l’avvio di una nuova forma di colonialismo che estende il capitalismo moderno a tutto il globo, perpetuando e anzi moltiplicando conflitti e fratture. Non solo all’esterno ma anche all’interno di territori e locali.

Questo scompiglio comporta forme di resistenza e di rigetto della modernità (o di alcuni suoi aspetti) e del suo individualismo, che possono spingere verso il recupero della tradizione, l’etnicismo e, nel caso più estremo, verso il fondamentalismo religioso, che con i suoi attacchi a icone e luoghi simbolo del potere euro-occidentale rende sempre più malsicura la nostra vita quotidiana, suscitando un clima di assedio e di paura che motiva all’opposto sfoghi xenofobici, nazionalismi e nuovi razzismi. Così le “guerre culturali” che siamo costretti a vivere sono il risultato da un lato del declino delle metanarrazioni e della crisi della prima modernità e dall’altro della sua estensione planetaria in termini economici, di valori e dello scardinamento dei meccanismi riproduttivi delle diverse società. Come dimostra il fondamentalismo stesso, in qualità anche di tentativo di riaffermazione del machismo e del controllo patriarcale di fronte al mutamento del ruolo della donna e delle sue nuove attese e richieste indotte dalla possibilità di confrontarsi con altri contesti e immaginare esistenze alternative. La globalizzazione, esercitando contemporaneamente pressioni verso l’unità e la frammentazione, l’assimilazione e la differenziazione, impedisce di valutare la realtà pensando unicamente alla convergenza e di trattare il problema della diversità culturale privilegiando solo prospettive etno-razziali o stato-nazionali.
Le differenze culturali operano oggi “tra” e “nelle” nostre società, come evidenziano tutti i dibattiti sul multiculturalismo, e sono sempre più instabili, impedendo la difesa sia di un punto di vista strettamente universalista, che apertamente relativista. Si estendono, moltiplicano e sviluppano riproducendosi o producendosi, affermandosi, facendo domande di riconoscimento o mescolandosi. Prospettiva quest’ultima su cui converge l’attenzione di Serge Gruzinski che, ne La Pensée Metisse, esplora i fenomeni di metissaggio e mescolanza all’interno delle culture dell’America latina a seguito della conquista e dell’occidentalizzazione imposta, distanziandosi sia dalla fissità delle immagini levi-straussiane sia dalla valorizzazione delle culture particolari proposta dai Cultural Studies. Il lavoro di Gruzinski è importante poiché permette di comprendere la natura del metissaggio come “reazione di sopravvivenza a una situazione instabile, imprevista e largamente imprevedibile” (Gruzinski Serge, in Wieviorka Michel, La Differenza Culturale, pag.63) e come soluzione alternativa all’affermazione collettiva e al suo irrigidimento.

Il mestizaje oltre a privilegiare uno spazio espressivo infrapolitico, articola una vera e propria combinazione di culture, o come osserva Burke, un’“unità nella diversità”, “mettendo l’accento sulla maniera in cui le culture si trasformano reciprocamente senza necessariamente condurre all’assimilazione” (Burke Thomas, in Wieviorka Michel, La Differenza Culturale, pag.64) né tantomeno al riconoscimento del particolarismo culturale o dello statuto di minoranza. Concentrando l’attenzione sulla creatività del soggetto dà luogo a interessanti trasformazioni provenienti dal basso che invece di pietrificare la differenza, come nel caso dei melting pot, la rendono itinerante, invitando a volgere lo sguardo non tanto verso le zone centrali dell’identità quanto piuttosto verso le frontiere, dove esso si origina e muove. La realtà della mescolanza rinviando liberamente all’intersoggettività oltrepassa le soglie della differenza collettiva, del dentro-fuori e della contrapposizione Noi-Loro, prospettando universi di senso inediti che non temono ambivalenze e contraddizioni, né l’incontro tra culture. Di qui l’idea che il metissaggio non riguardi semplicemente il contesto sudamericano ma più in generale ogni posizione frontaliera che sempre comporta: incontro tra identità e alterità, appartenenza alla molteplicità e invenzione.

La polifonia della frontiera consiste nelle sue pluripotenzialità, di cui il metissaggio è uno dei possibili orizzonti. La sua natura fluida lo distingue sia dal cosmopolitismo che dall’ibridismo, che sono altri modi per combinare le culture. Il cosmopolitismo consiste nella valorizzazione delle differenti culture mantenendo il primato dell’individualismo liberale. Il cosmopolita è un soggetto che vive a suo agio nella diversità conservando, contrariamente al meticcio, la propria autonomia, e combinando in maniera egocentrica le culture nelle quali circola senza parteciparne l’esperienza. Il cosmopolitismo è il sogno dell’occidente europeo, della sua storia e della modernità. L’ibridismo invece combinando culture senza storia né memoria (Burke Thomas, in Wieviorka Michel, La Differenza Culturale, pag.70) si distingue dal metissaggio proprio per mancanza di spessore storico, per questo motivo pare essere l’orizzonte della globalizzazione e della sua cannibalizzazione culturale. Esistono così diversi modi di guardare alla differenza, che vanno posti in relazione con i luoghi della sua elaborazione, le storie, le posizioni e le traiettorie della sua generazione e trasformazione.

Occorre poi distinguere tra differenze collettive e mescolanze, non separare la questione culturale da quella sociale, dal problema delle gerarchie, delle ineguaglianze e dell’esclusione, che oggi, connettendosi con la comunicazione e i diritti d’accesso, si estende a tal punto da comportare la completa e totale estromissione di alcune frange composite della popolazione planetaria e locale dalla cittadinanza, dalla politica, dalla cultura e dalla società civile. Ciò motiva anche una riflessione sull’inadeguatezza delle politiche del multiculturalismo e dell’assimilazione che le nuove ondate di migrazione pendolare e il binomio comunicazione-tecnologia stanno già facendo saltare. Mentre le prime ondate migratorie (si pensi non solo alle immigrazioni dalle ex colonie, ma anche alle immigrazioni dall’Europa all’America durante primo e secondo dopoguerra) insediandosi stabilmente nelle società d’accoglienza possono beneficiare delle politiche multiculturaliste e dello statuto di minoranze culturali accordato con più o meno facilità in relazione alla partecipazione economica (ethnic business o altro), quelle attuali, determinate da un contatto onirico con la modernità, intensificato dall’influenza dei media, si sottraggono all’istituzionalizzazione della differenza e alla necessità del riconoscimento nello spazio pubblico e possono rivendicare la loro appartenenza etnica come rifiutarla o oltrepassarla.

Sempre meno interessate alla contestazione politica e sociale entro i confini dello stato nazionale si muovono piuttosto come “sfere pubbliche diasporiche” connesse da reticoli globali, locali e delocalizzati. Di qui l’impossibilità di fare combaciare queste realtà sociali e culturali infra- e transnazionali con l’integralismo politico e culturale del multiculturalismo. Laddove infatti niente è fissato, dove la decomposizione e la ricomposizione sono regola, dove l’invenzione arriva a modellare persino le tradizioni, dove le identità sono oggetto di scelte altamente soggettive, il buon funzionamento del multiculturalismo si rivela necessariamente difficile, dato che ha bisogno di una certa fissità (Wieviorka Michel, La Differenza Culturale, pag.95), di interlocutori conosciuti e di gruppi ben definiti. Ovvero tutto il contrario del costante stato di flusso che caratterizza oggi le identità culturali che, sempre più prodotte che riprodotte, sono sottoposte a continui processi trasformativi, non solo legati a ineguaglianze e ingiustizie sociali, ma anche al rapporto con comunicazione, consumo, prima e seconda modernità.
Saggio tratto da Extended Mind. Viaggio, comunicazione, moda, città, a cura di Carlotta Petracci, anno 2006.