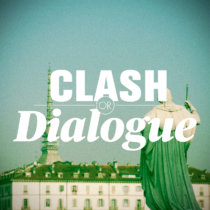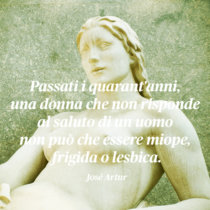La globalizzazione è una forma di neocolonialismo che anziché esercitare un dominio politico sui territori ne sfrutta e cannibalizza le risorse. Piuttosto che inventare alterità da governare, frantuma e divide le società sulla base della costruzione di un divario economico e culturale legato all’accesso. Tale consapevolezza non implica che si spieghino troppo sommariamente le questioni della differenza, dell’oppressione e della squalifica in funzione delle sole situazioni sociali. Anzi si tratta di affermare l’esistenza di un legame diverso, di uno sconfinamento, di una diluizione dei concetti di sociale e culturale, ricordando anche che appartenenza e produzione del sé, nella modernità contemporanea, sono problematiche che collegano globale, moderno, locale e psicologico. L’identità non si pone più esclusivamente come un problema filosofico, ispirato da un’etnografia del “comprendere”, ma anche soggettivo, personale, intimamente connesso alle proprie esperienze, transiti e dislocamenti.

La nuova prospettiva della diaspora come scelta comporta un’“etnografia del fuori”, dell’osmosi tra i tanti dentro e fuori del soggetto: una ridefinizione identitaria che passa attraverso l’ibridazione di alterità interne ed esterne; la declinazione al plurale di geografie interiori ed esteriori; il desiderio di modificarsi entro i propri spazi corporei attraverso una dialogica interiore; il sincretismo culturale; la mescolanza delle differenze, non solo etniche ma anche comportamentali, di stili di vita, visioni del mondo, sensibilità estetiche; il clash del trio estetica-etica-etnicità; il syn-tech (sincretismo tecnologico, in Canevacci Massimo, Sincretismi, pag.53); la transculturalizzazione dei valori, delle abitudini, delle economie, delle territorialità; la comunicazione interattiva; l’esperienza di essere sempre al confine della propria e altrui coscienza. Oggi la diaspora che, fin dall’inizio della modernità, ha costretto milioni di nativi, di africani e, dopo l’abolizione della schiavitù, di emigrati europei, asiatici, mediorientali a sperimentare l’alienazione, offre un nuovo scenario produttivo in cui tutto si può contaminare, deglutire, intrecciare ed espellere. Tale ricco disordine può spezzare il dominio culturale di quella stessa modernità che l’ha provocato, organizzato e nello stesso tempo temuto.

Le nuove identità diasporiche ‘performando’, attraverso le arti, una ricerca etnografica che mescola soggettività, collettività, storia ufficiale e storie singolari, familiare e alieno, esprimono sfide rispetto sia all’ordine dello Stato sia al controllo e all’assimilazione delle culture trapiantate o migrate in altri contesti, rompendo la stringente alleanza che l’Occidente ha saputo produrre tra Umanesimo universalista e nazionalismo autoctono; Illuminismo che proclama l’uguaglianza di tutti gli esseri umani e Illuminismo che perseguita quegli stessi esseri umani che prendono sul serio tale dichiarazione. La soggettività diasporica, disconnessa dalla propria matrice etnica, percorrendo gli interstizi dei tanti centri e periferie del mondo, sfalda, disaggrega, rende itinerante e plurale l’identità. Attaccando, attraverso proprie modalità auto-affermative, il potere immobilista del localismo e quello totalizzante del globalismo, ricrea incessantemente nuovi scenari che si autonomizzano dal peso delle sofferenze etno-storiche e si inscrivono nelle possibilità dell’Oltre-Uno.

Come nota Massimo Canevacci: “la prospettiva dei nuovi sincretismi si basa su una concezione delle diaspore non più legate alle forzose migrazioni, agli esili tragici, alla deterritorializzazione come sottrazione, bensì a una nuova soggettività che sperimenta lo scorrere delle proprie pluralità” (Canevacci Massimo, Sincretismi, pag.81), che rimodella culture e identità a partire dal passaggio dalla diaspora alle diaspore, dalla nuova importanza assegnata alle rotte (routes) rispetto alle origini (roots) e alle combinazioni rispetto alle sovrapposizioni. Di qui la percezione che il problema delle differenze sia assai mutevole e mobile. Non più semplicemente riconducibile all’affermazione, alla rivendicazione, al ribaltamento della squalifica, alla “costruzione” di identità attraverso l’odio del sé o il bricolage, ma in costante demoltiplicazione, traduzione e trasformazione dentro le nostre e le altrui società. “L’idea della differenza – come osserva Eleonora Fiorani – va pensata non come rigida e nitida, ma porosa, differenziata dal suo stesso interno e costituita, attraverso relazioni storico-spaziali, da alterità” (Fiorani Eleonora, La Nuova Condizione di Vita, pag.189).

Alterità che in un mondo in cui si allenta la compattezza dello stato-nazione e delle sue appartenenze e i valori dominanti sono sempre più quelli della flessibilità, dell’accettazione del rischio, dell’incertezza, della disponibilità alla comunicazione permanente, della possibilità di spostarsi, di cambiare mestiere, luogo di lavoro, delinea una complessa e frastagliata costellazione di posizioni, confini, pensieri, idee, immagini, valori, creatività antropofagiche e immaginazioni critiche in transito, comprensibili solo attraverso la volontà di continuare a estendere e rendere sempre più duttile la propria immaginazione cognitiva e morale. Continuare a trasformarsi col fine di costruire mappe polifoniche più adeguate ai territori lacerati, multivocali, intrecciati e dissonanti che l’oggi presenta. Mappe più utili a disorientare che orientare, incomprensibili più che comprensibili, non rappresentabili, e che siano il frutto di interpretazioni e smarrimenti che non possono essere oggettivati né universalizzati. Come già Gregory Bateson, in Verso un’ecologia della mente, aveva dichiarato, negando la possibilità di una reale oggettività data dalla presenza della soggettività.

La quale non è solo quella dell’osservato, ma anche dell’osservatore e che si avvale, nella sua costruzione e sperimentazione, di una ragione emozionata che, posta a contatto con l’alterità, si dimostra incapace di trascrivere una differenza sintetica, monologica o dialettica, comprendendo il valore della pluralità, della dialogica e della polifonia. Del godimento e del panico desiderante che altera, sincretizza e rende diasporica la ricerca, il contatto, l’incontro con l’altro da sé. L’altro dentro e l’altro fuori, l’altro fuori percepito come intralocale, che permette all’io dentro di porsi come extralocale, di farsi plurale, nella mescolanza, interazione elettronica e decodifica delle identità e delle identificazioni. Nella reciproca scoperta dell’altro e attraverso l’altro, di un sé mutante, inquieto, non-identico, frantumato e frastagliato. Un sé fatto a pezzi dal viaggio e dal transito, che non ritrova più una sicura collocazione nel cosmo, ma lo fa rientrare nella pluralità ‘egoica’ per attraversamenti, sconfinamenti, contrasti e contraddizioni.

Un sé che si compone di infiniti avatar e maschere, che nascono e muoiono come le emozioni e i desideri. Di qui l’importanza assegnata al discorso sull’apparenza, in relazione alle mutazioni identitarie di un corpo esteso e sconfinato, connesso e partecipato. Un corpo che, attraverso l’abito, si interfaccia col mondo e la sua incessante detonazione, nelle visionarie eventualità dell’essere contemporaneo, mutante e metamorfico. Come accade sia all’interno dei circuiti istituzionali della moda – John Galliano il pirata o l’impenitente Hussein Chalayan – sia al di fuori, nella strada: luogo delle invasioni visuali, degli sconfinamenti barbarici, del detournement e dei divertissement consumistici, delle sfide vive che aprono alla comunicazione dei saperi, delle culture e delle identità.
Saggio tratto da Extended Mind. Viaggio, comunicazione, moda, città, a cura di Carlotta Petracci, anno 2006.