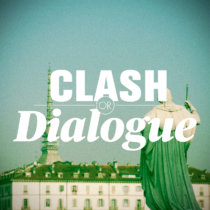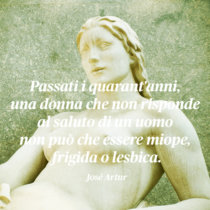È la modernità che va in frantumi. La solidità che si polverizza e cambia di stato nelle reti. È la difficile coesistenza di flussi e fratture, poiché il processo di alterazione della materia è complesso; è una questione di urti, temperature, tagli, innesti, suture, vischiosità: incontro tra artificialità, naturalità, spazio e società. Così il passaggio da una configurazione stabile, leggibile, trasparente a una disordinata, caotica, opaca, ricombinante è possibile solo attraverso una caduta, una interiorizzazione dello sguardo e una esteriorizzazione del vissuto. Attraverso l’apertura dei corpi, la lacerazione dei tessuti, la sottrazione degli organi, che divengono centri che irradiano emozioni, che incrociano in vario modo le reti dell’economia. Sollecitati nei luoghi del consumo, ricollocati attraverso i circuiti della tratta, utilizzati come sacche da quelli della droga e oggetto di fotografie still life nelle campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani per Benetton, anch’essi diventano merci, comunicazione e pubblicità. Testimoniano non il superamento, ma il cambiamento di stato della modernità; la sua estensione planetaria.

Una modernità in cui appare sempre più difficile stabilire chi dipenda da chi, attraverso i molteplici passaggi di segno che coinvolgono società e culture differenti. Curioso a questo proposito è il lavoro dell’artista messicano Miguel Angel Rios che, nell’installazione Flower Power, indaga il rapporto tra Potere e minoranze a partire dalla distorsione della pratica dell’assunzione di sostanze allucinogene nel passaggio dalla cultura indigena latino-americana alla controcultura occidentale degli Anni Sessanta: in cui la psichedelia, spogliata dei valori culturali e religiosi originari, diviene simbolo di antagonismo politico e culturale. In questo passaggio si produce un’alterazione del sistema di significazione che, attraverso il contatto tra due minoranze, promuove un sovvertimento delle distanze culturali. Come nota Teresa Macrì: “il passaggio di segno (la droga) da una minoranza all’altra acquista dei risvolti sociali interessanti: le fasi di passaggio invertono la rotta dominante (da sud a nord); questa rotta non è stata stabilita né imposta (dai detentori di segno); il segno viene capovolto nella sua significazione: da elemento naturale e regolamentato da un codice di vita (quello degli indigeni) diventa elemento “artificiale” di un codice alternativo” (Macrì Teresa, Postculture, pag.170).

Per opera del fenomeno hippy, interno alla cultura dominante, si procede a una ricombinazione che coinvolge e ribalta il ruolo della cultura dominata. Esemplificazione interessante di come in un mondo di traiettorie globali gli intrecci possano schiudere significati inattesi, che sembrano incomprensibili, finché qualcuno non li riporta alla luce: nelle città. Dove architetture, luoghi, persone, cose, merci, informazioni e immagini, in osmosi tra loro proiettano universi ansiosi e estranei alla perennità che intersecandosi costruiscono un ordine semantico in progress, sempre più complesso e terso. In cui le pulsioni del dentro e del fuori si rimettono in gioco e acquisiscono altri sensi, seguendo reticoli e percorsi distanti ma sempre intrisi di vicinanza e presenza. Nei territori metropolitani recinti funzionali, dai confini sempre più marcati e reti lunghe di servizi, che scardinano le appartenenze della fisicità si mescolano tra loro, si scontrano, si confondono e si separano di nuovo, dando luogo a paesaggi ibridi, dove isole di iper-concentrazione e sacche di riflusso si compongono in modo frammentario e aleatorio, lasciando dietro di sé pezzi e detriti che attendono di essere immessi nuovamente negli imprevedibili circuiti del consumo contemporaneo.

Attraverso bricoleur, nelle gallerie d’arte e nelle strade. Soggetti per il quali il riutilizzo si inscrive in una pratica di vita che non ha nulla a che vedere con la povertà o la marginalità (o comunque non solo, come molti sono spinti a credere), ma con una differente visione della cultura, come: produzione, distruzione, recupero, ricomposizione. Sfida lanciata alla spettacolarizzazione e alla museificazione. Soffio anarchico che costringe a dibattere su dialogo e rifiuto. A riflettere su buio, luce, trasformazione, assimilazione e diversificazione. A vivere in un tessuto urbano impazzito, disseminato di spazi, dai centri della finanza a quelli gentrificati, da quelli dell’interdizione, ai ghetti urbani, ai campi profughi , ai centri del consumo e del turismo – (Bauman Zigmunt, in Fiorani Eleonora, La Nuova Condizione di Vita, pag.116), alle terre di frontiera, ai quartieri multietnici.

Dove si fa esperienza di una costellazione frastagliata di spazi effimeri, dove comunità e soggettività immaginarie e nomadi si producono e riproducono, attraverso la disidentificazione, lo sradicamento, la deriva e il rifiuto o la perdita della casa. Manifestando anche l’incertezza dell’attuale società transnazionale; la complessità della moltiplicazione, dell’opposizione e dell’ibridazione di poteri, confini, ruoli, identità, alterità e culture. E ciò accade perché sia i soggetti che i luoghi, in costante rapporto con i panorami globali e locali descritti da Arjun Appadurai (mediorami, etnorami, tecnorami, ideorami), oggi transitano insieme. Si presentano cioè come incroci di reti e paesaggi deterritorializzati; trame di eventi materiali e immateriali che quotidianamente scorrono, si svolgono, immaginano, discutono e partecipano.
Saggio tratto da Extended Mind. Viaggio, comunicazione, moda, città, a cura di Carlotta Petracci, anno 2006.