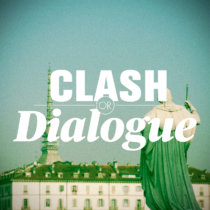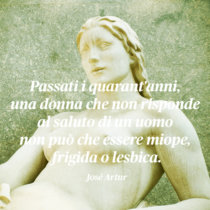“Lo spazio turistico è innanzitutto un’immagine. Immagine che si fanno i turisti e che danno gli organizzatori di vacanze. Immagine percepita con inquietudine a volte, sempre con sorpresa, dalle popolazioni autoctone. Immagine complessa, sogno, che compare su manifesti, guide, depliant, dipinti, libri, film. Immagine ed evocazione che i turisti portano con sé e trasmettono agli altri. Evocazioni, odori, suoni, sensazioni” (Miossec, in Minca Claudio, Spazi Effimeri, pag.49). L’aura dei luoghi sprigiona dalle loro immagini, da quel corredo di rappresentazioni e precomprensioni che fanno parte non solo della geografia individuale di ciascuno di noi, ma anche dello spazio simbolico che ci circonda. E il viaggio comincia nelle società di partenza, dove i turisti impalcano i loro sogni, sullo sfondo di un altrove sui cui convergono racconti del passato, del presente e desideri latenti dell’immaginario collettivo. All’immagine tradizionale dei luoghi – fissatasi lentamente nel corso dei secoli – oggi si sovrappone un complesso reticolo di immagini mediali che non solo muta il loro volto, ma che contribuisce a orientare le tendenze della moda e del consumo. Il lavoro promozionale degli operatori turistici in particolare assegna alle immagini dei luoghi delle valenze di natura commerciale, predisponendo delle offerte che incontrino i desiderata collettivi e promuovendo la costruzione di luoghi turistici, a cui poi richiamano attraverso strategie promozionali.

Il desiderio di autenticità, di esotismo, di fuga del turista si concretizza nei luoghi dell’offerta turistica, riducendo il viaggio verso l’altrove a una marcia incosciente che ha come unico obiettivo quello di verificare la bontà dell’immagine turistica o la corrispondenza tra immagine del luogo ed esperienza che ne deriva; precludendo in questo modo la comprensione di quei complessi processi di mutazione che derivano dall’incontro tra culture e delle culture particolari con quella globale. Il luogo rimane fuori dalla dialettica che interessa operatore e consumatore, la quale al contrario si fonda sulle performance dell’immagine pubblicitaria, che rimanda al luogo attraverso un mix di richiami rassicuranti e infarciti di stereotipi culturali. Su questi richiami esotici e rassicuranti si fondano le scelte del cliente e la competitività della destinazione all’interno del mercato turistico, attraversato anch’esso negli ultimi anni dalla tendenza alla personalizzazione dell’offerta di beni e servizi, che caratterizza le strategie dell’accumulazione flessibile e della produzione culturale postmoderna. L’estetica dell’effimero, che domina il quotidiano, sconfina anche nelle destinazioni turistiche, che ridisegnano la loro geografia a partire da quella moltitudine di immagini mediali che formano l’attuale visione del mondo.

La produzione di senso si perde così nell’escalation di informazioni che bombarda le nostre percezioni, per le quali rappresentazione e realtà sono già confuse, rimescolate l’una nell’altra. La rivoluzione telematica introduce nuovi dispositivi nelle nostre esperienze cognitive, comportando un’alterazione del nostro rapporto con la geografia, della nostra capacità di pensare e progettare il territorio e lo spazio sociale. L’implosione delle immagini in ogni dove mette in crisi il rapporto tra la rappresentazione e il suo referente reale, tra significante e significato, determinando il collasso di quella sequenza logica che dava ragione dell’investigazione scientifica moderna. Ad un mondo addomesticato ne segue uno sfuggente ed eccedente in immagini e rappresentazioni che, brillando di luce propria, divengono nuovi e ineffabili contesti, nuove realtà prive di memoria referenziale. Alla semplificazione succede l’iper-complessità della dematerializzazione, alle gerarchie una matrice senza centri né periferie e alla linearità della memoria la contemporaneità dei tempi e delle storie. Nell’iperspazio mediatico orbitano solo frammenti sottratti alla realtà – presente, passata, futura –, che non si lasciano ricordare se non a partire dal loro clamore. Queste forme vuote e prive di corporeità sono ciò che rimane di un mondo passante, in costante accelerazione e dominato dall’iperrealtà.

I territori, che assomigliano sempre di più alle immagini mediali e pubblicitarie che li ritraggono, si presentano allora come il prodotto non intenzionale dell’azione umana e il riflesso di una mediazione artificiale, confondendosi con le loro rappresentazioni, non rendendosi più disponibili ad un’investigazione d’insieme e svincolandosi da ogni pretesa di esaustività. In particolare la coesistenza di plurime geografie su uno stesso territorio dà ragione della discontinuità che segna il passaggio da una logica spaziale all’altra: dallo spazio costruito, ordinato e cartografato del moderno, a quello caotico, effimero e difficile da rappresentare del postmoderno che, formato e informato dalle reti telematiche, si ripensa all’insegna della spettacolarizzazione, della frammentazione, dell’autoreferenzialità, della connessione, della segregazione e dell’implosione. La ricostruzione di ambienti artificiali, che caratterizza l’evoluzione più recente del mercato turistico, tende a dare vita a microcosmi isolati fisicamente e completamente autosufficienti rispetto al territorio che li ospita, dove la mancanza di profondità, l’incoerenza dei segni, la lucentezza, la saturazione di stimoli, la riproduzione allegorica dell’Altro e dell’Altrove, la simulazione, l’euforia iconica e la ricostruzione iperrealistica di luoghi-simbolo della socialità, sono la manifestazione più compiuta del mutato spirito dell’epoca e della liquefazione delle distinzioni tra sociale, economico e culturale.
All’interno degli spazi del turismo – megamall, parchi tematici, grandi alberghi, resort e corridoi del trasporto globale – la logica postmoderna domina incontrastata: da un lato, dando ragione di una rottura col territorio circostante e i principi che lo orientano, dall’altro materializzando la possibilità di mondi alternativi rispetto a quello reale, privati delle sue insidie e ricostruiti a partire dal recupero di simbologie identitarie proprie degli spazi sociali tradizionali. Marc Augé li definisce nonluoghi, per la natura a-territoriale e il carattere non identitario che motivano il constante riferimento alla semantica del luogo e il richiamo evocativo a referenti immaginari o temi che fungono da riserve di senso necessarie per attirare la tourist gaze. Si tratta di spazi effimeri, universi conchiusi e autosufficienti che si presentano in superficie come un testo, come una facciata di immagini e una pellicola di luoghi comuni che appartengono all’immaginario collettivo del visitatore. Al loro interno tutto è pubblicità e citazione, e le uniche relazioni possibili sono anch’esse mediate da testi e sollecitazioni visive, nel contempo distanti e familiari. La riconoscibilità data dalla visibilità si traduce in garanzia di protezione e sicurezza, entrambe particolarmente gradite al turista che, straniero in ogni luogo, sente gravare su di sé il peso dell’incertezza dato dalla perdita di riferimenti stabili. Sintomatico non a caso è il senso di sollievo che si prova quando, proiettati in una situazione aliena, si ritrova nell’atmosfera ovattata di aeroporti, grandi alberghi internazionali o santuari del consumo, quel senso di sicurezza che l’ambiente esterno fa vacillare. Bisogno di protezione fisica e psicologica spiegano la particolare condizione di quarantena del turista che, muovendosi attraverso i nodi e le reti dello spazio globale, finisce per reiterare sempre il medesimo racconto di sé, escludendo l’esperienza dell’alterità e promuovendo il restringimento del suo spazio simbolico.
Saggio tratto da Extended Mind. Viaggio, comunicazione, moda, città, a cura di Carlotta Petracci, anno 2006.